L'America e il Mostruoso
Prendiamo Los Angeles. Mai nella sua storia, l’immaginario americano dell’apocalisse si è accanito con tanto ardore distruttivo come su Los Angeles. Che arrivi dall’acqua o dal cielo, sia causata da terremoti o da eventi cataclismatici dei più stravaganti (eruzioni vulcaniche, pestilenze, ere glaciali, collisioni con comete, esplosioni o raffreddamenti di soli, api, piranha, orche) la catastrofe immaginaria ha affondato, a intervalli regolari, i suoi artigli sulla “città degli angeli”. Mai una metropoli è stata doppiata, con tanto impalcabile zelo, da un immaginario del disastro così tentacolare. Non è andata meglio a New York. King Kong e il suo gemello Godzilla l’hanno, a turno, polverizzata. Alieni e pestilenze si sono dati il cambio per renderla un involucro vuoto, desertico, fumante. Mike Davis ha definito questa ansia da distruzione che percorre la cultura popolare americana un’“estasi funerea”, “un allegro olocausto”. Perché tanto accanimento nel sognare la Fine?
Hollywood è stata una potentissima macchina di diffusione di questa fascinazione. Entra in gioco, come scrive Susan Sontog, tutta una estetica della distruzione, di quelle “particolari bellezze che si possono reperire nella catastrofe e nel caos. Nella figura del mostro venuto dall’interspazio convergono il deforme, il brutto e il predatorio, fornendo un bersaglio fantastico al godimento estetico della sofferenza e del disastro”. Non solo: il disastro offre la possibilità di sperimentare – a livello estetico – ciò che è ontologicamente vietato all’uomo. “Lo spettatore cinematografico – insiste Sontog – può partecipare all’operazione fantastica di vivere oltre la propria morte, non solo, ma oltre la morte delle città e la distruzione della stessa specie umana”. Funziona in queste narrazioni uno schema archetipo: la catastrofe portata sugli schermi, viene - nel momento stesso della sua rappresentazione - esorcizzata, depotenziata. “Raffigurare un male, rappresentare un pericolo, simboleggiare un’angoscia - ha scritto Gilbert Durand -, significa già, attraverso il dominio del cogito, dominare tutto ciò. Ogni epifania di un pericolo alla rappresentazione lo minimizza”.
In questa morfologia della distruzione fantastica, possiamo cogliere tre “grandi” momenti. Il primo ha due protagonisti: uno scimmione – King Kong - e il suo antagonista, il grattacielo. Scomposto, terrificante eppure capace di gesti di umana tenerezza il primo. Immobile, chiuso nella sua sovrana indifferenza, a suo modo “parlante” il secondo. C’è il sospetto che i due siano in fondo “gemelli”, che articolino la stessa lingua, inscritti come sono entrambi nella dis-misura. Con King Kong “ha inizio la storia della reciproca esaltazione simbolica dei grattacieli e dei mostri o supereroi dell’immaginario” (Antonino Terranova).
Nella grande scimmia - “un catalizzatore automatico di miti”, secondo Alberto Albruzzese - è la natura che si ribella allo stra-potere della civiltà, scalando gli odiosi simboli della civiltà per venire da essi abbattuta. Questo privilegio accordato al naturale lega King Kong ad un altro personaggio che nel ritorno alla natura inscrive la sua essenza: Tarzan. Anche qui siamo davanti a un rapporto speculare: il mostro e l’uomo che riabbraccia la sua primigenia condizione. Che la “grande scimmia” e “l’uomo-scimmia” siano in qualche modo legati dal privilegio della genealogia?
Quella di King Kong e Tarzan in realtà non è la storia di un’adozione, ma di un esproprio. Tarzan “pone al centro dell’avventura coloniale il corpo muscoloso, costruito e rigorosamente bianco dell’eroe” (Giulia Fanara). Bianco è qui il colore chiave. Tanto King Kong evoca un mondo di tenebre, di agguati oscuri, tanto il bianco di cui è “rivestito” Tarzan significa purezza, trasparenza, innocenza. E’ il bianco Tarzan che, adeguatamente istruito dalla scimmia, diventa il “vero” signore della giungla. Dove c’erano tenebra e oscurità, ora riverbera il chiarore della sua pelle adamitica. Tarzan, il colonizzatore, sottrae al nero, all’indigeno, alla natura di cui Kong è l’ultimo simbolo, il suo territorio geografico e mitico. A King Kong si deve un altro “segreto”. Il suo essere ridotto a maschera spettacolarizzata ci dice qualcosa della contemporaneità nella quale siamo immersi: lo spettacolo come figura del mostruoso, un legame che resterà inscindibile fino a diventare “cifra” della società dello spettacolo. La morte di King Kong rappresenta la sconfitta della materialità, del “troppo corpo” (Francesco Muzzioli). La sua sconfitta segna l’inizio del secondo “momento” della nostra carrellata: l’epoca in cui la minaccia si avvicina nella forma dell’immaterialità, del “troppo poco corpo”, sotto la legge dell’invisibilità. E’ la minaccia atomica che dominerà l’immaginario Usa a partire dagli anni ‘50.
L’Invasione degli ultracorpi – baccelli giganti che si appropriano delle forme umane per insediarvi il loro proliferante potere - è la trascrizione di questa nuova inquietudine: l’incapacità di dare un corpo al nemico che avanza protetto dall’invisibile. Gli alieni assumono l’aspetto di persone normali. “Nell’invasione degli ultracorpi tutte le forme di normalità sono rovesciate. Gli amici non sono amici, la polizia non protegge, il sonno non è rigenerante, i telefoni non sono più un mezzo per chiedere aiuto ma uno strumento per far sapere alle persone baccello dove si trovano le restanti persone non baccello” (Stuart Samuels). Insomma ciò che è familiare diventa “gravido di pericoli”. Non siamo più, come con King Kong, nel regno dell’invasione fragorosa e spettacolare, ma nel tempo dell’infiltrazione mimetica. Non nell’alterità che assume l’evidenza parossistica del gigantesco, ma nella diversità che si camuffa nella forma dell’“identico”.
Il terrore di incubare qualche cosa di ostile, estraneo e mostruoso, qualcosa che si mescola al familiare e al vicino, appartiene anche alla mitologia di Alien, l’alieno venuto dallo spazio che cerca di “fecondare” corpi umani per garantirsi una progenie. “Alien rimane ai bordi: non approda alla Terra, non penetra nella città, non sconquassa la metropoli come un qualunque Godzilla. Figura liminale, fa del proprio essere sempre ai margini un elemento di ulteriore minacciosità: non è qui, ma potrebbe esserci” (Gianni Canova).
A questa silenziosa infiltrazione reagiranno gli eroi di carta: i supereroi del fumetto. Ancora ibridi: l’erculeo Tarzan abbandona la giungla per entrare stabilmente nella metropoli, universo seriale fatto di grattacieli, di automobili, di velocità impazzita. Niente più liane: per muoversi nella “foresta di pietra” i figli di Tarzan si serviranno di tele sottili e prensili (l’Uomo Ragno), di mantelli alati (Superman) o di mezzi ipertecnologici (le macchine-protesi nelle quali è incapsulato il corpo di Batman). Ma per far fronte al nuovo scenario post-moderno, alla metropoli che lo domina, il corpo di Tarzan non basta più. I suoi muscoli sono inadeguati, goffi. Il corpo deve attrezzarsi di nuovi poteri, deve sfondare i propri limiti. La famiglia dei supereroi si inscrive nel regno della contaminazione. Se ogni supereroe è portatore di un’inedita strategia, vi è tuttavia un codice comune a tutti: quello zoomorfo.
Nel momento in cui l’umanità ha smesso di intrattenere rapporti magici o rituali con il mondo animale, e l’animale viene spogliato di ogni significazione ulteriore rispetto al suo “uso e consumo” -, l’uomo ne trasfigura l’immagine, nella forma – ancora una volta - dello spettacolo. Ma quale animale? L’universo Walt Disney è stato una potente macchina di spettacolarizzazione di questo mondo “pacificato”. Fatto a misura d’uomo. “Walt Disney – ha scritto Oreste De Fornari – ha creato un’Arcadia in cui le distanze tra uomo e natura sono accorciate e si comunica facilmente con gli animali, un’Arcadia piena di animali parlanti, edificanti, esilaranti, terrificanti, poco o molto umanizzati, dove la gerarchia tra specie viventi vacilla e ci viene ricordata continuamente l’umanità dell’animalità e l’animalità dell’uomo”. Zio Paperone e suo nipote Paperino incarnano non le astuzie degli animali, ma i vizi degli uomini. Più che farsi portatori dell’alterità animale, essi trasfigurano le “piccolezze” umane - la cupidigia di zio Paperone, l’indolente ritrosia al lavoro del “nipote” -, rendendole accattivanti, perché in fondo comuni non all’animale ma all’uomo. Il territorio delle loro storie non è ontologico (differenza uomo-animale), ma morale (laboriosità/indolenza, avidità/generosità). Diversa è la strategia di comunicazione tra i due regni (umano e animale) di cui è portatore l’Uomo Ragno. Il mondo animale torna, ma nella forma rapinosa e avvelenata del morso. Non più pacifica convivenza degli opposti, ma morso, appunto, violazione. L’Uomo Ragno incarna questo raddoppiamento. In lui si combattono due esseri, l’uomo e il ragno: uno è la morte dell’altro, uno abita l’assenza dell’altro. L’animale e l’uomo non possono comunicare che nella forma della sostituzione. Non è un caso che il corpo di Spider man sia inguainato in una maschera che ne ottunde e occulta qualsiasi apertura, a significare che ogni comunicazione tra i due mondi è impossibile.
Questa dimensione ancestrale, questa ritorno del primordiale non basta. C’è una nuova generazione di supereroi che si fa largo. All’origine del nuovo corpo che si impone c’è “l’assoluta, drammatica, sconvolgente, unione integrativa corpo-macchina in un groviglio pazzesco e virtualmente inestricabile” (Alessandro di Nocera). Non più l’animale ma la macchina. Non la natura ma la materia. Non il passato o l’istinto: ma il futuro, l’evoluzione. L’agente di questa trasformazione è la radioattività, la “sofferta mutazione a livello molecolare”.
Esemplare è la storia dei Fantastici Quattro, uscita dalla matita di Jack Kirby. Un gruppo di pionieri dello spazio sta violando una delle Colonne d’Ercole dell’umanità. Ma la navicella sulla quale viaggiano è investita da invisibili raggi cosmici. I corpi dei Fantastici Quattro sono sconvolti. E’ la mutazione al lavoro. Il corpo umano viene, nella trasposizione fumettistica, esteso (fino a diventare plastico), la sua materialità viene esaltata (è roccia) o negata fino a farsi invisibile (la trasparenza), la sua capacità operativa diventa implacabile (si fa fiamma). All’iconografia della catastrofe che colonizza progressivamente l’immaginario della metropoli americana, si affianca un altro disastro: quello del corpo umano. Un corpo incapace, così come è, privo del corredo percettivo necessario ad armonizzarsi a questo iperspazio, di adeguarsi al nuovo ambiente metropolitano. L’altro della nostra società non è più la natura, ma l’artefatto.
Che si tratti di cinema, fumetto o letteratura il copione resta lo stesso. Nella messa in scena della catastrofe è mascherata “una celebrazione – ricodificata e aggiornata – dell’antica liturgia del successo” (Francesco Dragosei). La scansione dell’evento catastrofico segue uno schema fisso. Un uomo e uno solo - l’eroe - ha la capacità di leggere i segni dell’avvicinarsi del disastro. E’ un uomo isolato. I suoi ripetuti allarmi vengono ignorati o derisi. Chi dovrebbe proteggere la città (o l’intera società, o l’intero pianeta) dalla distruzione è implicato in essa, ne è complice, ne vuole approfittare per ciechi giochi di potere. Il disastro si materializza in un crescendo mozzafiato: distruzione, caos, morte, disperazione. L’eroe, fino ad allora misconosciuto, viene invocato dalla comunità indifesa, in balia di forze superiori. Per lui scocca l’ora del riscatto. Il suo intervento è salfivico. E’ la sua genialità, la sua prontezza, la sua cocciutaggine – la genialità, la prontezza, la cocciutaggine di un individuo solo – a salvare la città, la comunità, il pianeta. La crisi è superata, la comunità ritrovata, l’americano medio “eroicizzato”. L’apocalisse finale, quella che cancellerà tutto, è solo rimandata.



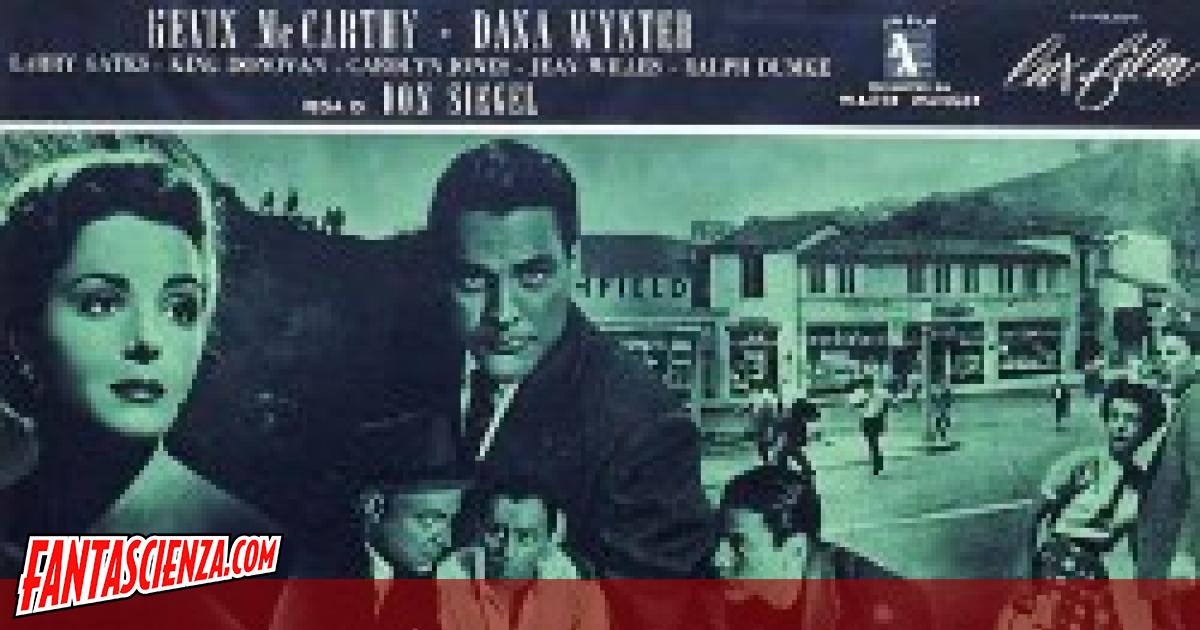

waroftheworldspic.jpg)


Commenti
Posta un commento